Ci sono dei libri che interrompi dopo le prime due pagine e ce ne sono altri che vorresti che non finissero mai. L’ultimo di Michele Gambino, “Un pezzo alla volta. Storia di un giornalista e del suo tempo” (Manni editore), fa parte del secondo caso.
Duecentoquaranta pagine di storie vere, di impegno civile portato avanti attraverso il giornalismo di Giuseppe Fava, di cui “Miki” – come si firmava ai tempi de “I Siciliani” – è stato uno degli allievi più brillanti.
Un giornalismo di prima linea, di frontiera, la Catania degli anni Ottanta e Novanta, i cavalieri del lavoro, Nitto Santapaola, i morti ammazzati, le grandi corruzioni che attraversavano le istituzioni più importanti, le banche trapanesi, i collegamenti con Riina, con Provenzano, con Gelli e con Sindona.
E poi il lavoro di inviato speciale con un altro giornale mitico, “Avvenimenti”, unica testata di proprietà dei suoi lettori, le grandi inchieste su Gelli, sulla la P2, su Gladio, sulle stragi fasciste e mafiose, e poi il Libano, l’Iraq, l’Afghanistan, l’ex Jugoslavia, la Colombia. Un giornalismo mai paludato, ma sempre finalizzato all’unica missione che il direttore gli aveva indicato: la verità.
Un libro che fa battere il cuore, perché ripercorre il modello di scrittura impartito da uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo come Fava. Un libro da leggere assolutamente.
“Questa non è la storia di uno che alla fine vince qualcosa – scrive Gambino – . Ho visto molte cose, ho viaggiato per il mondo raccontando storie, ho combattuto alcune battaglie e le ho perse. E pur col giusto grado di amarezza che si accompagna alle sconfitte, non direi mai che battersi è stato inutile: quel che conta è aver vissuto la vita pienamente, aver acceso una scintilla ogni tanto in qualcuno dei ragazzi che mi ascoltava, poter dire a mia figlia che ho provato a consegnarle un mondo migliore, e almeno ho cercato di non essere tra quelli che lo hanno reso peggiore”. Chi scrive è stato uno di quei ragazzi che ti ha ascoltato. E che ti ringrazia (luciano mirone)
Quello che segue un brano del libro:
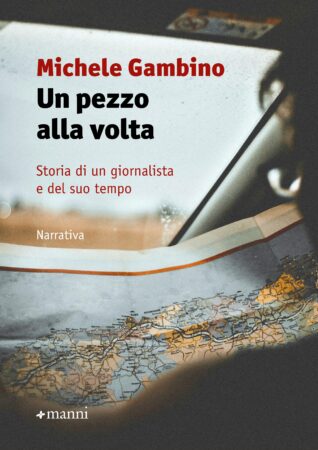
La copertina di “Un pezzo alla volta. Storia di un giornalista e del suo tempo (Manni). Sopra: il giornalista e scrittore Michele Gambino
“Una domenica pomeriggio sono di turno in redazione e chiamano dalla polizia: sulla circonvallazione c’è stato un incidente. Sul posto ci sono i vigili urbani che misurano la distanza tra una buca profonda e un motorino fracassato. La ruota del motorino è finita nella buca, il ragazzino alla guida è volato e ha battuto la testa. Lo hanno portato via in ambulanza. Il ferito si chiama Alfio, ha quindici anni. Devo capire in quale ospedale l’hanno portato, parlare con i parenti, chiamare il fotografo. Torno in redazione e faccio il giro telefonico degli ospedali. Alfio non è arrivato da nessuna parte. Poi a sera mi dicono che è morto in ambulanza. Ci metto un paio di giorni per ricostruire la storia: l’ambulanza ha fatto il giro degli ospedali catanesi in cerca di una tomografia assiale computerizzata che accerti il tipo di lesione. In tutta la città però quella domenica non c’è una tac funzionante, quindi l’autista ha deciso di raggiungere Messina, cento chilometri più a nord. Il ragazzo è morto all’altezza di Taormina: in quel punto la corsia dell’autostrada s’affaccia sulla spiaggia di ciottoli candidi, lambita da un lato dagli aranceti e dall’altro dal mare; il puzzo di benzina e d’asfalto è coperto da un denso sentore salmastro. Se non altro un bel posto per morire.
Scrivo il pezzo e l’indomani il direttore mi chiama. Lo ha colpito la doppia maledizione di Alfio: la buca nell’asfalto e la mancanza di una tac funzionante. Qui dobbiamo capire due cose, dice: perché sulle strade di Catania ci sono buche grandi come vasche da bagno? E perché non c’è una tac funzionante in una città di seicentomila abitanti?
In Sicilia – dice – le tragedie dipendono spesso da una mancanza. Ogni mancanza dipende da una ruberia, ogni ruberia da un potere.
Mi lancio sulla pista delle tac e trovo un medico che mi spiega come funziona la faccenda, a patto che non faccia il suo nome: le tac degli ospedali pubblici non funzionano perché non devono funzionare. Non ci vuole molto: basta allentare un elemento, evitare di sostituire un pezzo danneggiato, non fare il tagliando di garanzia al macchinario quando serve. Il posto in cui invece le tac funzionano benissimo sono le cliniche private. Il seguito è molto semplice: il primario dell’ospedale pubblico prescrive una tac al paziente, che viene dirottato verso un laboratorio o una clinica privata perché il macchinario pubblico non funziona. Il proprietario della struttura privata è un prestanome o un parente del primario. Ogni anno centinaia di milioni finiscono nelle casse dei privati per prestazioni che le strutture pubbliche potrebbero erogare, se le apparecchiature funzionassero.
Ci sono risvolti dolorosi: la povera gente si rivolge alle banche per poter anticipare la spesa che poi verrà rimborsata tutta o in parte dal sistema sanitario. Se le banche non concedono il prestito, ci sono gli usurai.
Faccio delle visure alla camera di commercio e scopro che i primari coinvolti sono tutti vicini alla Democrazia Cristiana, area andreottiana. Alfio è stato sfortunato: quella domenica di luglio nessun laboratorio privato si è scomodato ad aprire.
Poi c’è la storia della buca. Gli abitanti del quartiere mi raccontano che è lì da mesi, e ha provocato parecchi spaventi e corse in ospedale. I vigili urbani hanno ricevuto decine di segnalazioni ma le hanno ignorate tutte.
Chiedo un appuntamento all’assessore alla Polizia urbana. Mi riceve l’indomani nel suo ufficio. È un uomo alto, il corpo grasso e pesante come preso in ostaggio dall’abito blu, la cravatta stretta sul colletto della camicia troppo largo, la barba di due giorni, gli occhi acquosi. Intorno alla sua scrivania sono seduti alcuni uomini trasandati. La stanza odora di birra, di sudore e di fumo, come una sala giochi di periferia.
L’assessore risponde alle mie domande a monosillabi, sforzandosi di usare l’italiano. Non sa niente di buche, e non sa dirmi a quale ditta sia stato affidato l’appalto per la manutenzione delle strade. Quando gli dico che ho fatto una visura catastale, e ho scoperto che l’impresa in questione risulta di proprietà di una vecchietta nullatenente, sbuffa e cerca aiuto con lo sguardo nei suoi compari, che mi fissano muti e ostili.
Pochi mesi dopo l’assessore diventerà sindaco di Catania. Negli anni Novanta me lo ritroverò davanti sul banco dei testimoni dell’aula bunker di Palermo, durante un’udienza del maxiprocesso. Deve rispondere di certe foto che lo ritraggono abbracciato a Nitto Santapaola, il capo della mafia nella Sicilia orientale. «Non sapevo chi fosse», dice sotto giuramento”.


























Lascia un commento...